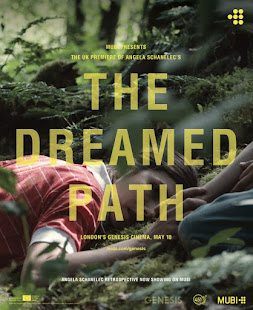Scambio
video-epistolare tra il decano degli avanguardisti americani, Jonas
Mekas, ed il purtroppo non molto conosciuto regista spagnolo José
Luis Guerín, le missive del primo sono oggetti piuttosto grezzi,
traballanti, caotici, fuori fuoco, commentati in un inglese che
starebbe bene in bocca al cowboy di un western, hanno un sapore quasi
amatoriale, casalingo, di improvvisazione, ma è evidente, nel
proposito di Mekas, che la patina approssimativa sia assolutamente in
linea con quella che è la sua filosofia: il suo fare film, il suo
riprendere, è una reazione all
’esistere,
praticamente una diretta promanazione; le lettere visive di Guerín
sono invece più ordinate e (almeno apparentemente) più elaborate,
il bianco e nero ci riporta al vagabondare di
Guest (2010)
tanto da pensare che molto del materiale lì non utilizzato sia stato
poi riproposto in
Correspondencia Jonas Mekas - J.L. Guerin
(2011) senza comunque accusare alcuna ripetizione, anzi, ancora una
volta Guerín esplora le potenzialità di una settima arte che è
giacimento inesauribile di metodi, raccontarsi attraverso di esso,
raccontare la propria professione nel riflesso disomogeneo di un
collega. Pur non risultando esteticamente così complementari, le due
vedute si connettono in una concettualità alta e nobile che dona un
senso di insieme in cui oltre, ovviamente, all’attenzione verso il
cinema, si annusano anche cose profonde e inintelligibili che stanno
dentro la vita, nonché la vita tout court.
Che ora è?... sono le tre del mattino... tutta questa faccenda della
realtà, della poesia [incomprensibile]... io filmo, io registro,
video-registro momenti di vita intorno a me, amici, la mia vita,
dettagli, che ho bisogno di registrare, e per quale ragione proprio
non so cosa mi spinge a farlo, ma devo farlo, io devo solo farlo. Poi
le persone, dopo, mi chiedono quale è il senso di tutto ciò, cerco
di razionalizzare ma è solo un gioco, è un giocare con le parole […
o i mondi?]. Il fatto è che quello che vedi e quello che faccio sono
momenti, frammenti che ho registrato con la mia videocamera
esattamente come la vita procede, va avanti, così è tutto reale, ma
non giro h24, filmo solo qualche momento ogni giorno o ogni secondo,
così il mistero rimane: perché filmo ciò che filmo? Perché ho
fatto questi quindici secondi, o uno o due minuti? E perché non di
più? Così... questo è il bello della vita, noi andiamo avanti e
nessuna spiegazione è necessaria, le spiegazioni sono solo parte del
gioco, quello che ti sto dicendo ora è solo per tenermi sveglio,
buonanotte José Luis.
Il
close-up strettissimo di Mekas che proferisce il discorso sopra
trascritto è il vertice della corrispondenza, del resto è
presumibile che ogni regista con un minimo di coscienza ad un certo
punto si sia chiesto: ma perché filmo? (e automaticamente uno
spettatore altrettanto coscienzioso dovrebbe domandarsi: ma perché
guardo?), il valore di un quesito così profondo e radicale non potrà
essere di certo svelato da un signor nessuno come il sottoscritto, al
massimo ci annotiamo delle suggestioni: Guerín filma perché segue
le parole di Mekas, “i react to life”, perché la capanna di
Thoreau è ancora in piedi sulle sponde del lago Walden, perché la
triste storia di Nika Bohinc e del suo compagno merita di essere
ascoltata all’infinito, perché anche in una normale ripresa di
persone che camminano in una piazza polacca permane la speranza di
poter carpire un significato superiore, perché gli occhi di
Malgorata Zavinska hanno visto molto, perché anche due formiche che
a fatica trascinano su per un muro un per loro enorme pezzo di
qualcosa vale la pena che venga registrato. Ci sono mille pulsioni,
mille spinte, mille salti in un vuoto colmato poi dagli esemplari
artistici generati, nient’altro che lo specchio delle inquietudini
vissute, delle muse ispiratrici agognate. Tra le righe
Correspondencia ci
dice di tutto questo, nel dialogo a distanza tra Mekas e Guerín si
leggono i dubbi, le paure ma anche l’entusiasmo nel fare un
mestiere che deve essere bellissimo, a Mekas, come in cielo, e a
Guerín, così in terra, diciamo che tale mestiere, nella loro
personale declinazione, è, per noi, anche stupendo da vedere.