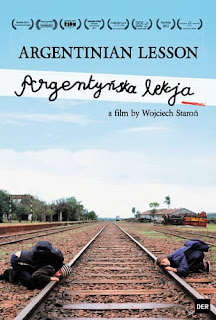È una storia di
emigrazioni Argentynska lekcja (2011), film firmato da
Wojciech Staron, principalmente direttore di fotografia, che si gioca
dall’inizio la carta della sottrazione; nella ripresa di una comunità
d’origine polacca stabilitasi in Argentina il regista punta
all’essenzialità e allora ecco tanta camera a mano con
annesso pedinamento dei ragazzini in scena, dialoghi risicati e
probabilmente parecchia improvvisazione. Ciò che viene a galla
è una ricerca su un realismo naturale in cui Staron tenta di
farsi fantasma, la sua trasparenza nonostante le inquadrature
ravvicinatissime lascia i protagonisti apparentemente a loro agio
dimostrandosi per lo più “veri” al nostro occhio,
parimenti è però difficile non avere qualche
perplessità sull’andamento che costituisce Argentinian
Lesson, partendo come documentario (quasi) puro con
l’introduzione di Marcia si ibrida trasportando il tutto in un
limbo abbastanza tiepidino, chi scrive ritiene che in casi del genere
il raggiungimento di un equilibrio tra finzione e non è una
meta ardua da raggiungere che se mancata rischia di provocare una
diffusa disomogeneità, il che, sempre a mio umile modo di
vedere, è quanto accade nel film di Staron, ci sono dei
deficit tra le componenti che lo istituiscono, a taluni episodi si
guarda con indifferenza (di base: in una situazione dove non accade
granché [o meglio, è più Staron a non fare di
quel “niente” qualcosa di più] quanto appeal ha la vicenda
di una famiglia polacca in Sud America?), ad altre con leggero
sospetto (l’intensificato snodarsi dell’amicizia tra Janek e
Marcia o le vicissitudini di quest’ultima).
È comunque un film
strano Argentynska lekcja, pur avendo un’identità
incerta e pur non raggiungendo i sessanta minuti di durata, contiene
al suo interno l’accenno a svariate tematiche, ma la susseguente
trattazione zoppica. L’argomento che fa da miccia, ovvero
l’emigrazione dalla Polonia all’Argentina, si riduce a qualche
parentesi dove i figli dei migranti tentano di studiare la lingua
parlata dai propri genitori. La portata principale dell’opera
localizzata nel concetto di amicizia è, smentitemi pure nel
caso, alquanto piatta e prevedibile, posso apprezzare lo spirito dei
piccoli sullo schermo ma qui ci si ferma. A rimorchio abbiamo poi la
questione della scarsa abbienza con delle forzature notevoli (Marcia
alle prese con vari lavori) che inquinano la naturalezza della
storia. Mi preme dire che non è tanto il fatto in sé ad
essere stonato (di undicenni che lavorano nei paesi poveri ce ne
saranno fin troppi), quanto come ci viene proposto, forse c’è
troppa celerità nel collage che Staron offre e quindi al
posto di poter sentire oltre il vedere, vediamo e basta, il che è
sempre avvilente per una sana propensione alla Visione. A bilanciare
un paio di immagini si trattengono con piacere, l’ultimo sguardo di
Janek in camera, con il successivo stacco sui titoli di coda, rimane.