Et in terra pax (2010) è film che non va disdegnato a fronte di elementi che prima della visione potrebbero seminare dei dubbi; queste le parole chiave che suscitano suggestioni più o meno legittime: realismo (neo-neo?), Roma, Pasolini (ieri), periferia, delinquenza, Garrone (oggi).
La rotta di questo film co-diretto da due esordienti naviga per mari di cemento che hanno inevitabili reminescenze di quell’uomo con gli occhiali neri (cit. Vasco Brondi) e, visto il successo recente, delle cronache annichilenti di Gomorra (2008). Il debito nei loro confronti non è però una ferita incurabile, tutt’altro: Botrugno e Coluccini fanno un film di strada dimensionato nel luogo ripreso rifiutando le indagini socio-politiche in favore di ritratti simultanei, convergenti e urgenti, di alcuni abitanti del Serpentone. Il Serpentone, risultato di un’architettura figlia del big-bang economico, cova al suo interno i nipoti indolenti di quell’epoca; qui il film non sorprende granché visto che la modellazione dei bulli rispecchia il profilo immaginato da un “esterno”, il terzetto protagonista (impersonato da attori professionisti) è, infatti, scritto con la penna dei telegiornali, ma, è il caso di dirlo, è scritto sufficientemente bene.
L’attenzione verso il percorso deformativo del trio è più compatto di quanto possa sembrare perché il loro “ciao” allo spettatore è rappresentato da una scenetta puerile in cui rubano un cellulare ad un bambino. L’evento, apparentemente privo di significato, descrive come e quanto in un posto del genere la distanza tra te e l’abisso sia un niente: da un telefonino ad uno stupro lo scarto è minimo. Il paesaggio (umano) circostante soffre di una medesima impostazione derivativa, storielle di droga, di violenza, di omertà, insomma, debolezze distruttive non affatto impensabili in un contesto del genere. Eppure le cose girano. Il barista, i boss del quartierino, le relative donne, la nonnina, la ragazza che tenta di alzare la testa dalla merda, il pentito: sarà la verace amalgama romanesca o sarà l’intreccio più che dignitoso, fatto sta che la pellicola lievita quando è giusto che lo faccia.
Botrugno e Coluccini utilizzano un canale di trasmissione paratelevisivo (Romanzo criminale ha fatto scuola) contrassegnato però da note personali apprezzabili: interessante la panoramica dell’anfiteatro con l’enorme struttura incombente su di esso, e la scena madre che adopera l’escamotage del dettaglio (le braccia) per usare sapientemente il fuori campo come parte attiva della sintassi. La locuzione latina del titolo fa parte di una preghiera cattolica che poi Vivaldi musicò in una delle sue Gloria, i registi piazzano tale coro in tre punti strategici del film laddove i primi due creano un’anticipazione che si concretizza nell’irruenta conclusione: tre pistolettate, e pace in terra agli uomini di buona volontà.


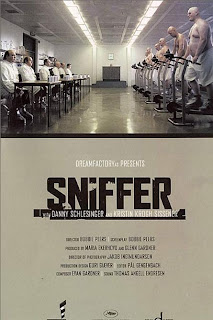









.jpg)






