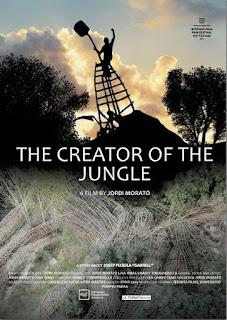Non mi sento di biasimare
nulla al regista israeliano classe ’77 Avishai Sivan per un motivo
molto molto semplice: Tikkun (2015) è nel complesso un gran
bel film e proprio di complessità si occupa, mica questioncine
accessorie!, il terreno di gioco vede infatti due grandi contendenti
del persempre che sono la Vita e la Morte, e da qua, cari lettori,
non si scappa, invece Sivan scappa anche allargando le maglie della
sua opera per farvi filtrare ulteriori tematiche che comunque si
presentano costantemente sottoforma antitetica in una connessione
nadirale e zenitale che ben si sposa con la veste estetica, bianco e
nero come carne e spirito, tradizione e rivoluzione, prigione e
libertà, padre e figlio, Dio e dio. Ma soffermandoci un poco sulla
componente estetica è necessario sottolineare di quanto essa sia un
fattore fondamentale della pellicola perché sarà pur vero che
quando si parla di ultraortodossia una religione può valere l’altra
ma Sivan filmando all’interno del quartiere Mea Shearim (la zona
più conservatrice di Gerusalemme) ci fornisce una testimonianza di
seducente alterità che attraverso uno stile ieratico si scolpisce
con discrezione nelle nostre pupille le quali restano ammaliate da
queste figure golcondiane in salsa mediorientale, dal loro esserci
umbratile all’interno del quadro, dall’apparire nera massa
indistinguibile ma anche singolarità malinconica e fantasmastica nei panni di
uomini anacronisticamente agghindati, c’è, in sostanza, un sottile
magnetismo sprigionato dai soggetti nello schermo che si traduce in
un fascino visivo per nulla convenzionale.
A ben vedere nel rapporto
padre-figlio il regista, finanche sceneggiatore, ripone parecchie
letture significative poiché confrontando due istanze che via via si
fanno sempre più divergenti, emergono con lo srotolarsi narrativo
delle correlate nonché inevitabili incrinature, ed ecco perciò il
ritornare alla condizione crasica e critica di molteplici duplicità
in guerra tra loro, se il genitore rappresenta la ligia tradizione
reazionaria, il ragazzo dopo la “resurrezione” scardina la gabbia
della propria vita e se ne va a zonzo (non senza un filo di gradita
ironia) riproducendo un moto di meravigliata autonomia, e ancora: se
il primo, una volta appurato lo spirito di ribellione del
primogenito, inizia ad essere tormentato da incubi in cui Sivan rompe
il velo contemplativo per iniettare gocce di surreale e dove il senso
di colpa dell’uomo nei confronti di Dio si tramuta in un remix
Abramo-Isacco (che qui si concretizzerà poiché il macellaio, anche
se indirettamente, sarà responsabile della morte definitiva del
giovane, l’incidente infatti riguarda una delle mucche da lui
liberate), Haim-Aaron più che rinnegare il proprio credo si libera
di quella paura che invece attanaglia il papà (animalizzata dal
coccodrillo) e si inerpica in un sentiero che invece di portare al
Signore porta a se stesso, e come il film illustra non si tratta
affatto di un percorso agevole.
Merita due parole anche
un altro spiccato dualismo che forse arde più degli altri
all’interno di Tikkun poiché in una pellicola così votata
ad una ricerca di trascendenza emerge una tensione sessuale che
sebbene affiori solo in pochi momenti è capace di terremotare tutto
quanto, non è un caso allora che il protagonista batta la testa in
seguito ad un’erezione generatasi dal ricordo delle labbra di una
sconosciuta, quindi ad una dimensione spirituale incastrata in uno
scenario che parrebbe impossibile da inquinare, irrompe una carnalità
che è proprio tale: è carne, e lo si intende già
dall’inizio con lo scotennamento di una mucca i cui tessuti una
volta riposti nel frigo verranno sfiorati da Haim-Aaron come se
fossero un sesso femminile (la scena, per rimanere in tema di doppi,
si attuerà effettivamente nell’ottimo finale nebbioso), perciò
un’immissione erotica nel sigillato recinto dogmatico fa esplodere
da dentro gli assiomi introiettati nella testa di quello che alla
fine è un ragazzo come gli altri, e ritengo che mettendo un attimo
da parte le grandi materie etico-esistenziali che Tikkun
affronta, il brillio che folgora maggiormente è dato da quel senso
di smarrimento, di non sapere cosa ne sarà della vita che
conduciamo, di bramare comunque il femmineo, in cui è implicato
Haim-Aaron e che riguarda ognuno di noi cattolici, musulmani,
buddisti: esseri umani.